La società contro lo Stato di Pierre Clastres (1934 –1977), antropologo francese allievo di Levi-Strauss, è un testo fondamentale dell’antropologia politica e rappresenta una tappa necessaria per tutti coloro che desiderano davvero entrare nella cultura, nel pensiero e nella dimensione di quelle che vengono definite società “primitive” o “selvagge”. Clastres si occupa soprattutto della tribù dei Guayakì, nell’attuale Paraguay e dei Guaranì, popolo che vive principalmente nel Brasile meridionale, in Paraguay e in alcune aree di Argentina, Uruguay e Bolivia.
L’opera è composta da undici brevi saggi, apparsi nell’arco di un decennio, a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, in diverse riviste. Ogni saggio si occupa di una specifica tematica. Il tema centrale è il Potere, o meglio: il Potere politico
Il Potere politico
Clastres coglie subito una distinzione netta che evidenzia già nella prime pagine del suo testo: secondo l’antropologo francese c’è un errore sostanziale nel modo in cui viene percepito il potere politico in occidente e l’errata definizione di questo potere porta ad un’errata divisione della società. È da qui che deve muovere l’antropologo. La suddivisione delle società in società che hanno potere e società che non hanno potere è totalmente errata. Il potere politico coercitivo, quello basato su relazioni gerarchiche autoritarie, tipico delle società occidentali, è una tipologia particolare di potere, non universale. Esiste una forma di potere non coercitivo, caratteristico delle società cosiddette “selvagge” . Parliamo sempre di un potere ma non di un potere coercitivo. La prima grande intuizione di Clastres è esattamente questa: le società si dividono in società con potere politico coercitivo, le società storiche e società con potere politico non coercitivo, le società non storiche. Da questa distinzione Pierre Clastres mette in sequenza un concetto più geniale dell’altro per dimostrare come la visione etnocentrica occidentale non solo non riesca minimamente a cogliere la complessa struttura delle società amerindiane ma sia un grosso ostacolo allo sviluppo stesso dell’antropologia.
Clastres intesse tutta la sua sagace, precisa e acuta argomentazione sulla logica del potere e di come sorprendentemente, queste società, ignoranti e incolte agli occhi dell’occidente, siano riuscite a generare una straordinaria impalcatura del potere e abbiano, subito dopo, consapevolmente deciso di abbatterla. Queste società, dice Clastres, sono caratterizzate “dalla totale mancanza di autorità e hanno proprio nella mancanza di stratificazione sociale e nella mancanza di autorità del potere i tratti distintivi della loro organizzazione politica”.
Il potere è quello che la società ha voluto che fosse: Nulla.
Il potere è riconducibile al nulla, perché il gruppo rifiuta l’autorità e attiva di conseguenza una negazione assoluta del potere. Clastres riesce ad evidenziare, con una strepitosa capacità osservativa, che culminerà nel concetto del “dovere di parola”, che sancisce la netta separazione tra potere e parola, i tratti distintivi di questo potere. Esso viene innanzitutto identificato con la natura. Viene istituito affinchè gli si neghi subito ogni potenza effettiva e viene presentato al solo scopo di essere annullato. “Il potere viene venerato nella sua impotenza”.
Il (non) legame tra potere e parola
Il colpo di genio dei Guayakì si traduce nella concezione del legame, anche se sarebbe il caso di chiamarlo non legame, tra potere e parola. Qui Clastres riesce a cogliere una sottilissima sfumatura. È dentro la parola, che non è un diritto, ma un dovere, che si cela il mistero del potere depotenziato. È dentro l’inconsistenza e l’inefficacia di un discorso che si nasconde il segreto dei Guayakì. il capo è obbligato a pronunciare il discorso ma il gruppo non è obbligato ad ascoltare quello che egli dice. Viene messo in scena un vero e proprio capolavoro teatrale. Per questo popolo il capo è colui che parla. Lui ha il monopolio delle frasi. Lui solo è il Signore delle parole. Deve parlare se vuole essere il capo. Un capo che non parla non può essere il capo. Ma nel momento in cui comincia il discorso ecco che la platea appare distratta; nessuno mostra interesse a uno dei momenti “vitali” per la comunità. C’è chi si diletta in attività manuali, chi dorme, chi guarda, chiacchiera, chi sghignazza, chi sbadiglia. Il capo inizia a parlare, nell’indifferenza generale, con voce decisa e tono solenne ed elogia gli avi, il loro coraggio, le loro abilità, le loro doti. Più lui si accedente nell’enfasi narrativa, meno il pubblico si concentra sulla sua figura e non degna ad esso che qualche fugace e freddo sguardo .
“È un discorso vuoto”, dirà Clastres, “perché non è un discorso di potere. Il capo è separato dalla parola perché è separato dal potere”.
La parola del capo Guayakì non può essere parola di potere perché in questa società senza Stato il potere non si trova presso il capo. La parola del capo non è detta per essere ascoltata. Qui Clasteres intercetta un qualcosa che forse non tutti avrebbero colto. La loro è un’esibizione incredibile, che dimostra non solo come essi abbiano una precisa conoscenza del potere, ma soprattutto come riescano magistralmente ad erigerlo e a distruggerlo a proprio piacimento. Nella società primitiva è impossibile che nasca il desiderio di possesso perché è impossibile che nasca il desiderio di potere.
Scambio, opposizione e canto nelle società senza Stato
Ci troviamo di fronte a una società senza Stato, senza economia perché la rifiutano, senza storia perché non ne hanno bisogno, non inclini all’accumulazione, che misurano quotidianamente i reali bisogni da soddisfare; società dove la politica è presente pur non essendoci niente che ricordi una seppur minima istituzione politica. Società totalmente estranee all’idea di impartire un comando oppure di obbedire a un ordine, erette su un concetto di dono e di scambio delle cacciagione, elemento fondante di una coesione sociale da far impallidire la visione classica di questi due concetti, dove le opposizioni nettissime tra uomo-cacciatore e donna-raccoglitrice si estendono ai loro attrezzi, l’arco e il canestro, strumenti che sono il segno e l’antitesi di due stili di vita opposti e separati, ma che sembrano volersi compenetrare in più punti. Infine il canto. Dirà Clastres che le donne Guayakì cantano “piangendo”, accollandosi tutti gli aspetti negativi dell’esistenza, mentre gli uomini, costretti a dividere spesso la propria moglie con un altro uomo (in questa società vige la poliandria), e a dover dipendere come detto, dal dono della cacciagione da parte di un altro cacciatore, perché a loro è proibito mangiare la carne della preda che essi stessi uccidono, nel canto “celebrano” i valori e i piaceri dell’esistenza e si ricongiungono a se stessi. Per questo in quel preciso istante ognuno di essi si riscatta, si riappropria della sua essenza, si celebra in quanto uomo, come autentica individualità. Il canto non si scambia, non si divide. È pura improvvisazione personale.
Un capolavoro dell’antropologia politica
Pierre Clastres ha dato vita a un’ opera antropologica davvero di altissimo livello . La società contro lo Stato è un capolavoro dell’antropologia politica. Ma è anche un testo che oggi, incredibilmente, non si trova in commercio. È un testo che nessuna casa editrice desidera stampare. La speranza è che La Feltrinelli e l’editore Ombre Corte, che tempo addietro hanno pubblicato l’opera, decidano di puntare nuovamente su La società contro lo Stato. È inammissibile che un lavoro del genere non venga divulgato. Pierre Clastres è certamente scomodo, manda in crisi il mito occidentale della storia e della politica, dello Stato e del potere. Accusa senza pietà l’etnocentrismo occidentale additandolo come male assoluto, critica aspramente le suddivisioni umane che tendono a far prevalere un popolo nei confronti di un altro, a voler collocare un gruppo sociale in un gradino più elevato, rigetta inoltre alcuni criteri di arcaismo come l’economia di sussistenza, per non parlare poi del suo totale rifiuto riguardo al concetto di razza.
Egli traccia un profilo magnifico di questo mondo sperduto ma straordinariamente autentico, fa rivivere nelle sue intense pagine un popolo magico, unico, sterminato dalla cosiddetta “civiltà avanzata”. Un popolo che aveva anche una propria concezione del mito, di come è avvenuta l’origine del mondo e una singolare visione dell’unità: l’uno è male. A dirlo sono i Guaranì. Il bene non è il molteplice ma è il due. I Guayakì, dal canto loro, s’inventano tra le altre cose una nuova forma di scrittura. Non decidono infatti di scrivere su pergamene, carta o pietra ma sul corpo degli uomini. La loro scrittura è questo: segno profondo sull’individuo. La società deve marchiare il corpo dei giovani perché il marchio è un ostacolo all’oblio e il corpo è una memoria. L’antropologo francese, a coronamento della sua indagine etnografica, chiude la sua opera con queste parole:
“La storia dei popoli che hanno una storia è la storia delle lotte di classi. La storia dei popoli senza storia è la storia della loro lotta contro lo Stato”.
Non esiste un’unica versione della vita umana. La vera versione della vita, diranno gli antropologi, coincide con tutte le versioni della vita umana. E questo, forse, è il più grande insegnamento.

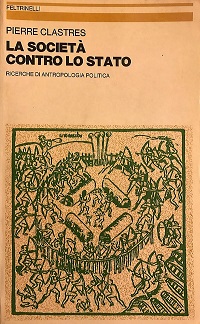
Commenti recenti